Siti Internazionali
Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.
Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.
Bambini dentro

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
→
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Crescere dietro le sbarre

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Lo scuolabus arriva puntuale alle 7.35. Maria attraversa il portone blindato senza voltarsi, stringe la mano della mamma e si incammina con il suo zaino rosa sulle spalle. Prima di salire le stampa un bacio sulla guancia. E’ sola, sul pulmino: gli altri bambini non devono sapere dove vive Maria. Perché la casa di Maria è diversa. Maria vive in carcere.
Non è l’unica, Maria. Ci sono anche Raayn e Armando, Mariam e Gabriele, Miriam e Michael. Ventuno, sono. In tutta Italia. Sono “i” ventuno: bambini che hanno meno di sei anni e vivono con le mamme detenute che stanno pagando per gli sbagli che hanno fatto. Innocenti. Tutti quanti. Incolpevoli. Tutti quanti. Indifesi. Tutti quanti. Eppure: la prima cosa che vedono quando aprono gli occhi sono le sbarre alle finestre e la prima cosa che capiscono è che la mamma non giocherà con loro al parco e non li accompagnerà alle feste degli amichetti.
Questo è il racconto dei 21. Di chi sono questi bambini e di come vivono con le loro madri. Ma è anche la storia di chi ogni giorno, nel carcere e fuori, con fatica, impegno e professionalità, prova a cancellare quelle sbarre dalla loro vita
Ascolta "Bambini dentro (di Alessandro Di Meo e Matteo Guidelli)" su Spreaker.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Bambini dentro
Bambini dentro
Gli Icam, le case famiglia e la promessa della ministra
“Mai più bambini in carcere. Anche un solo bambino costretto a vivere ristretto è troppo”. Davanti al Parlamento, lo scorso 17 febbraio, il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha ribadito quello che è il primo obiettivo del governo. Ma, come dimostrano proprio i 21 che ancora vivono dietro le sbarre, riuscirci è compito molto più arduo.
In realtà, dei ventuno bambini, quelli che ad oggi si trovano in un carcere vero e proprio sono 6 e sono tutti nella sezione femminile di Rebibbia, insieme a 4 madri, due delle quali hanno condanne definitive. A gennaio non ce ne era nessuno e a fine febbraio c’era un solo bambino: sono numeri che cambiano ogni mese e in ogni caso si cerca di ridurre al massimo il numero dei piccoli nei penitenziari. Per tutti gli altri, invece, la loro casa si chiama Istituto a custodia attenuata per madri detenute, Icam. Introdotti con la legge 62 del 2011, sono strutture dedicate esclusivamente a donne con figli fino a 6 anni, età che sale a 10 se la pena è definitiva. La legge di 11 anni fa ha previsto anche le case di famiglia protette, senza però indicare alcun onere per lo Stato. Il risultato è che le case famiglia, in tutta Italia, sono soltanto due, la casa di Leda a Roma e l’associazione Ciao a Milano.
La strada per cambiare la situazione, però, è aperta. Un primo passo in avanti c'è stato con il via libera della Camera a una proposta di legge del deputato del Pd Paolo Siani che individua nelle case famiglia protette l’unico luogo dove possano vivere i bambini figli delle madri condannate, prevedendo l’obbligo per lo Stato a finanziarle, e introduce alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a rendere possibile la detenzione negli Icam solo in presenza di “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”. Con la legge di bilancio 2020, inoltre, il governo ha stanziato 4,5 milioni per il triennio 2021-2023 proprio con l’obiettivo di potenziare le case famiglia. “Con questa disponibilità finanziaria – ha detto la ministra in Commissione Infanzia - si apre dunque una possibilità in più: spetta ora alle Regioni e agli Enti locali farsi carico di concrete iniziative nel settore dell’accoglienza delle detenute-madri”.
Saranno i prossimi mesi a dire se, finalmente, si riuscirà a portare a zero quel numero. Nel frattempo, i bambini continuano a vivere in carcere e negli Icam. Di questi ultimi ce ne sono cinque in Italia ma uno, a Cagliari, è vuoto. A Venezia c’è un solo bimbo, nove piccoli vivono invece nell’Icam di Lauro, in provincia di Avellino: il più grande ha nove anni, il più piccolo quasi 2; altri tre bimbi sono nell’Icam di Torino, associato al carcere de Le Vallette e altri due in quello di Milano, che dipende dal carcere di San Vittore ma è esterno alla struttura penitenziaria. Quale sia la differenza fondamentale con un carcere, lo spiega il direttore dell’Icam di Avellino Paolo Pastena. Sono strutture “pensate dall’inizio con determinate principi che rispondono ad un’esigenza fondamentale, quella di non far sentire o comunque attenuare al massimo grado l’impatto del minore con una struttura di tipo penitenziario. Il personale svolge servizio in borghese, c’è un ampio ricorso alla videosorveglianza, si cerca di tenere gli spazi quanto più aperti possibile”.
Tre anni fa, nel 2019, i piccoli in carcere erano molti di più: 48, più del doppio di quelli di oggi. Ed erano saliti a 59 all’inizio del 2020. Poi però è arrivato il Covid. Ed è triste constatare che il virus sia riuscito laddove le norme e la società, finora, hanno fallito. Ma è solo il primo paradosso di questa storia in cui la realtà è molto più complessa di quello che sembra. Dove la volontà deve fare i conti con i pregiudizi. Ci sono le responsabilità dei magistrati di sorveglianza, che hanno un’ampia discrezionalità sulla concessione delle misure alternative. Ci sono le condizioni oggettive di queste madri: la mancanza, per molte, di un domicilio vero e contesti familiari di assoluta indigenza che renderebbero l’alternativa dei domiciliari peggiore del carcere. E c’è un rifiuto generalizzato della società a ‘proteggere’ queste donne, e dunque a reinserirle in un contesto sociale e lavorativo adeguato, una volta concluso il percorso carcerario.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Bianca e le altre, storie di possibilità negate

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Sul comodino di Bianca c’è un libro, in copertina c’è la famosa bambina con il palloncino di Banksy. Il titolo è “La sfortuna dietro l’angolo” e lo ha scritto lei. Perché quel titolo Bianca? ”C’è chi nasce fortunato e benestante, con una famiglia che ha tutto, e chi nasce con meno. Io purtroppo non ho avuto questa fortuna, sono cresciuta in una famiglia povera, senza un padre, con una madre che era malata. Ero già responsabile a 10 anni, dovevo prendermi cura della casa, dei miei fratelli e di tutto il resto. E tutta sta sfortuna mi sta perseguitando”.
Quasi sempre, dietro una madre in carcere, c’è un passato di sofferenza. Bianca come Patrizia, Refko come Alina. Donne che non hanno mai avuto davvero la possibilità di scegliere, schiacciate da uomini e famiglie che, invece, avrebbero dovuto proteggerle. Un discorso che non vale per tutte, dicono gli operatori e i volontari che lavorano ogni giorno con loro, ma per la maggior parte sì. Un passato che molto spesso è anche il loro presente visti i contesti familiari da cui provengono e l’assenza totale di una rete di protezione. Ed è per questo che, paradossalmente, fuori dal circuito carcerario avrebbero meno occasioni per farcela.
Ognuna di loro si porta dentro traumi e paure. Patrizia ha 40 anni e 10 figli. Si è sposata giovanissima. Cinque glieli hanno tolti, il primo marito aveva problemi d’alcol e lei non era in grado di occuparsene. Non sa neanche dove siano. La sesta, una ragazzina che oggi ha 13 anni, avuta con un secondo uomo per colpa del quale oggi è in carcere, è in comunità. Poi è arrivato un altro compagno, un egiziano con il quale ha avuto altri quattro figli. Tre sono in Egitto con lui e anche questi non li abbraccia da anni. L’ultima, Mariam, che ha quasi sei anni, è con lei nell’Icam di Lauro. “Io lo voglio dimenticare tutto il passato – dice con gli occhi che le si velano di lacrime - quando uscirò di qui non voglio portarmi tutte le sofferenze sulle spalle, no. Voglio solo la felicità dei miei bambini. Continuerò a fare la mamma come ho sempre fatto, solo questo per i miei bambini”
Anche Refko dice di aver fatto tutto per i suoi figli. Lei è nell’Icam di Torino, dove vive con Raayn, cinque anni, il più piccolo dei suoi 4 figli. Il più grande, 21 anni, è in carcere, gli altri due di 14 e 17 sono in una comunità in Liguria. “Sono stata sempre una buona mamma e non ho mai fatto mancare niente ai miei figli – ci dice - Ho fatto quello che ho fatto, ho rischiato, sono andata a rubare e l’ho fatto per i miei figli che non hanno avuto un padre. Io ero viva, presente, Non li dovevo far soffrire. Non lo accettavo”. Ma ti penti di quello che hai fatto? “No – risponde – non mi pento di quello che ho fatto per i miei figli”.
Refko sta pagando per i suoi sbagli. E qualche rimorso in realtà ce l’ha. “Mi pento perché se mi miei figli si sono allontanati è colpa mia”. Si ferma un attimo, poi riprende: “Ho fatto tanta galera nella vita mia, non avevo mai capito, ma questa galera e questa lontananza dai miei figli mi ha fatto capire tante cose. Certe volte dico che se non ero entrata in carcere non avrei capito”.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Le bugie e la normalizzazione del carcere, i rischi per i bambini

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Raayn lascia la mano della volontaria che lo riporta in carcere da scuola, salta in braccio alla mamma con gli occhi che ridono e corre in giardino a giocare a pallone. Gabriele si mette in testa un elmetto giallo e finge di essere un operaio, mentre con Tracy litiga per un pezzo di Lego. Maria, invece, scoppia in un pianto senza fine che neanche l’abbraccio della mamma riesce a fermare, quando è il momento di salutare la cagnolina Mirta e la sua accompagnatrice. A vederli così, i sedici che vivono dietro le sbarre, sembrano bambini come tutti gli altri. Ed è l’ennesimo paradosso di questa storia. Perché a questi piccoli è permesso in carcere di essere bambini davvero, cosa che molto spesso per non dire sempre, fuori, non gli sarebbe concessa. Vanno a scuola, tutti i giorni, sono seguiti costantemente dal punto di vista educativo, psicologico, sociale. Fanno visite mediche ogni volta che ne hanno bisogno e hanno giochi di ogni tipo, che molti altri bambini liberi non hanno mai visto nelle loro case.
Poi però c’è il rovescio della medaglia. Perché un carcere resta un carcere, anche se si fa di tutto per cercare di renderlo più umano possibile. Il rapporto madre-figlio è una delle prime questioni, una delle più spinose. Perché le madri quasi sempre non raccontano ai figli la verità. “Se io dico al bambino una bugia, mino dall’inizio il rapporto fiduciario che c’è tra me e mio figlio – spiega la criminologa del carcere delle Vallette di Torino Marisa Brigantini – Io devo dire la verità al bambino, utilizzando parole che lui possa capire, e devo utilizzare situazioni reali perché non posso dire sono in carcere perché ho rotto un vetro, perché faccio crescere un bambino con il trauma che se rompo un vetro finisco in carcere”. I bambini devono sapere la verità con parole che capiscono, ma spesso questo non basta. “Bisogna anche usare il senso che lui capisca. Ma la verità va detta perché il bambino prima o poi verrà a sapere cosa è successo e a quel punto la madre sarà una persona di cui non si può fidare”. Un concetto ribadito anche dal direttore dell’Icam di Lauro Paolo Pastena. “Il bambino conserva il suo contatto con la madre però esce per andare a scuola, per la passeggiata con i volontari, per le attività. E ad un certo punto la domanda alla mamma viene quasi spontanea, mamma perché non puoi venire con me? Queste limitazioni creano nel bambino un sentimento di particolare difficoltà ma creano anche nella mamma dei sensi di colpa”.
L’altro grande problema per questi piccoli è la ‘normalizzazione’ del carcere. Ancora Brigantini. “Se un bambino rimane in carcere per tanto tempo c’è l’interiorizzazione di tutte una serie di situazioni penitenziarie. Il bambino che mi dice ah tu non ti rendi conto ma io sto crescendo dietro le sbarre, magari non si rende conto oggi di cosa mi sta dicendo ma domani questa roba lui la ricorderà”. Va trovato, quindi, un punto di equilibrio. E soprattutto, va evitato che il bambino torni nell’ambiente che lo ha portato in carcere. “Se torniamo in quel contesto per lui essere stato in carcere sarà stata la normalità. Ho avuto una persona in un altro carcere che quando gli ho detto ma scusi ma lei sarebbe contento che i suoi figli venissero in carcere, lui mi ha guardato con aria stranita e mi ha detto ‘ma certo e normale, c’è stato mio nonno, c’è stato mio padre e ci verranno anche loro”.
E qui si arriva al terzo nodo, forse il più difficile da affrontare perché richiede un cambio culturale. Ce ne parla Simona Massola, educatrice all’Icam di Torino. Succede infatti che nel circuito carcerario i bambini sperimentano diverse possibilità che poi si interrompono quando la madre ha finito di scontare la pena. “Diciamo sempre che il carcere non funziona. Ma se poi fuori non ci sono i servizi che possano rafforzare il lavoro che si cerca faticosamente di fare qui a tutti i livelli, se la società non ti sostiene e ti continua a bollare come ex detenuto, come madre che si è portata addirittura il figlio in carcere, è ovvio che poi queste persone non ce la fanno”. “E non è solo colpa del carcere che non ha funzionato – conclude con amarezza - ma della società che non ha saputo” sostenere il loro sforzo.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Milano, il primo Icam e il libro per non mentire

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Lungo le pareti sono appesi 380 quadri, uno per ogni madre che ha lasciato un pezzo di vita in queste stanze dalle grandi finestre, dove le sbarre ci sono ma sembrano quelle di un palazzo qualsiasi di fine ottocento. Nel giardino c’è un piccolo orto urbano e la recinzione alta 6 metri è camuffata con pannelli di plexiglass, per cercare di rendere un po’ più umani i simboli del carcere.
L’Icam di Milano è stato il primo ad aprire, nel 2006, cinque anni prima della legge che ha formalmente aperto gli Istituti per le madri. Un progetto pilota che ha fatto da apripista per tutti gli altri. La palazzina a due piani che lo ospita si trova in una strada tranquilla nella zona est e quelle mura ne hanno visti passare di bambini: in un’altra epoca era il brefotrofio di Milano, l’istituto che accoglieva i piccoli abbandonati o illegittimi. E’ l’unico in Italia fuori dal perimetro carcerario ma proprio questa caratteristica fa sì che sia anche l’unico in cui le detenute sono sempre chiuse dentro. Possono chiedere di uscire in giardino quando vogliono, ma la porta che le mette in contatto con l’esterno è sempre chiusa. All’interno la struttura è una grande L con un primo corridoio in cui c’è la sala colloqui, la biblioteca, la lavanderia e un altro con la cucina, le stanze e la ludoteca, che si riconosce dal cartello ‘E’ qui la festa’ appeso sopra l’ingresso. Lo visitiamo un sabato mattina durante la pet terapy con Mirta, una cagnolina meticcia che i due bimbi ospitati prendono subito in simpatia. “Il nostro progetto è duplice – racconta la responsabile Marianna Grimaldi – preservare la tutela del minore e sostenere la genitorialità”. Garantire da un lato che i bambini frequentino la scuola, facciano le attività di tutti gli altri bimbi e stiano fuori dalla struttura più tempo possibile e dall’altro lavorare sulle madri il tempo necessario a costruire quel percorso di alfabetizzazione e formazione che consenta poi di proseguire il lavoro in una casa famiglia protetta. Insomma, un progetto ‘circolare’ in cui tutte le istituzioni sono coinvolte, a partire dal Comune, che mira a dare un futuro a madre e bambino e non solo a gestire il periodo di detenzione. E il motivo è chiaro. “Si dice nessun bambino in carcere. Benissimo – spiega Grimaldi - Ma l’alternativa sono i domiciliari, se le mamme continuano a commettere dei reati. Se noi le mandiamo ai domiciliari, le nostre coscienze sono tranquille, ma dove vanno e cosa fanno davvero questi bambini? Cosa succede a questi invisibili? Non importa a nessuno. Il carcere non risolve certo i problemi, ma vogliamo chiederci dove è la società? Perché se fuori non c’è una società che si fa carico di queste persone, che tradimento facciamo ai bambini?”.
Proprio nell’ottica di lavorare sulle madri, all’Icam di Milano hanno messo in piedi un progetto dal quale è nato un libro. Si chiama ‘Mamma, dove siamo?’ Molto spesso, infatti, queste donne non hanno il coraggio di spiegare ai propri figli dove si trovano e perché sono in carcere. E così dicono bugie. Più sono reiterate e più si rischia di minare il rapporto con il proprio figlio. Nel libro le figure che ogni giorno ruotano attorno ai bambini diventano così personaggi della fiaba: la casetta nel bosco è l’icam, i folletti sono gli agenti della polizia penitenziaria, le fatine del bosco sono le educatrici. E poi c’è il tasso, che rappresenta la Giustizia. “ma perché mamma tu non verrai con me?” “Sai piccola, non sempre si può fare quello che si vuole. Esiste nel bosco un essere molto saggio, il Tasso, che decide quando le mamme dell’Icam possono uscire dalla porta magica”. La bambina confusa chiese: “perché mamma è lui che decide?” “Anche noi adulti, come i bambini, possiamo commettere degli errori. Quando questi errori sono troppo grandi il vecchio tasso decide che dobbiamo trascorrere del tempo nella casetta nel bosco. Per me la porta si aprirà solo quando il saggio tasso me lo consentirà”.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Educatori e volontari. L’esercito al servizio dei bambini

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Li accompagnano a scuola. Parlano con le maestre. Li portano al parco e in piscina. Giocano con loro. Cercano di capire i loro problemi. Soprattutto, non smettono mai di lavorare per farli sentire come tutti gli altri bambini. Sono gli educatori, i volontari, gli agenti della polizia penitenziaria, gli psicologi e i medici che lavorano negli Icam, un esercito di donne e uomini fondamentali in realtà come queste dove, non va dimenticato mai, i piccoli sono liberi e hanno gli stessi, identici diritti di tutti gli altri loro coetanei.
“Noi – spiega Federica Barile, educatrice all’Icam di Milano – siamo quella figura che rappresenta un ponte con l’esterno. Siamo noi che a livello pratico ci occupiamo dell’accompagnamento dei bimbi a scuola, delle uscite sul territorio, della socializzazione con l’esterno e allo stesso tempo siamo noi che restituiamo alle mamme ciò che accade all’esterno e che portiamo all’esterno quello che vorrebbero dire le mamme più da un punto di vista quotidiano”. In realtà sono molto di più: sono zii e zie che hanno con questi bambini legami molto più forti e profondi dei loro parenti veri, quelli che molto spesso spariscono o non ci sono mai stati.
Le parole del sostituto commissario Felice Galeotalanza, che sovrintende l’Icam di Avellino, sono inequivocabili. “Questi bambini sono eccezionali. Molte volte entrano qui con un aspetto quasi tendente al severo ma il rapporto, la sinergia, l’empatia che si crea tra noi operatori e loro, perché i bambini sono esseri puri e legano facilmente con chiunque si mostri loro amico, fa sì che alla fine l’agente di sezione diventa la zia e il comandante lo zio”.
Per tutti loro non esistono fine settimana e non esistono feste. Con i bambini ci sono anche a Pasqua e Natale, perché i piccoli non possono e non devono essere lasciati soli, non devono sentire l’assenza di affetto. Nunzia questo legame fortissimo lo conosce bene visto che uno dei piccoli di Lauro ha deciso che lei è la sua fidanzata: così ogni volta che lei si allontana comincia a piangere e battere i piedi. “Il nostro obiettivo principale – dice la ragazza - è quello di dare al bambino un’opportunità di uguaglianza, siamo tutti uguali e non vi è nessuna differenza. Noi cerchiamo di far vivere loro la quotidianità e di rendere possibile qualsiasi cosa”. Nunzia racconta che a Carnevale lei e le sue amiche si sono travestite e hanno organizzato una festa, a Natale si sono dati da fare per costruire il cartone con il presepe. E poi ci sono le feste di compleanno. Perché molto spesso questi piccoli una festa tutta loro non l’hanno mai avuta.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
L’Icam di Avellino, due sezioni per nove piccoli

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Dall’esterno è solo l’ex carcere per i tossicodipendenti: una recinzione alta 10 metri circonda il grande muro di cinta verde all’interno del quale c’è la struttura vera e propria dove alloggiano le detenute. Ma dentro, l’Icam di Lauro è tutt’altra cosa. Innanzitutto, è il luogo dove vive la maggior parte delle madri che si trovano in carcere con i propri figli: ce ne sono 9 delle 15 che ancora sono dietro le sbarre, con 9 bambini, quattro femmine e cinque maschi.
“Se noi consideriamo l’Icam dal punto di vista dell’istituto penitenziario, probabilmente non riconosciamo in questa struttura le caratteristiche tipiche di un carcere – sottolinea il direttore Paolo Pastena – ma se lo raffrontiamo ad una casa familiare, quella a cui noi siamo abituati, è chiaro che siamo molto distanti anche da questo modello. E’ una soluzione di compromesso”. Che la trentina di uomini e donne della polizia penitenziaria, gli psicologi, i medici, i volontari e gli educatori cercano di rendere quanto più possibile una casa accogliente.
Sulle pareti delle due sezioni, l’Azzurra e l’Arancione, sono dipinti i personaggi delle favole: Mary Poppins, Biancaneve. Le stanze sono venti in tutto: 4 sono singole, un letto più la culla e il bagno, mentre le altre 16 sono in realtà veri e propri miniappartamenti. C’è la stanza da letto, una zona giorno con angolo cottura, un bagno. Durante il giorno le porte sono sempre aperte, si fa un ampio utilizzo della videosorveglianza, che però non è attiva all’interno delle stanze, e le detenute possono andare dove vogliono all’interno della struttura: c’è l’infermeria, la ludoteca, una grande cucina, la sala sociale per vedere la televisione, un grande cortile all’aperto con gli scivoli, il calcio balilla e i giochi per i bambini, un teatro. C’è anche una biblioteca con i computer dove durante il Covid i piccoli hanno potuto seguire le lezioni in Dad e dove ora, grazie all’impegno di cinque docenti che si alternano, sono le madri a seguire i corsi di alfabetizzazione. “Pensieri sparsi per immergersi nelle nostre emozioni” è la traccia sulla lavagna che le donne devono sviluppare su un cartellone.
Ogni iniziativa, ogni attività è pensata per tutelare il bambino. Anche nei dettagli: i piccoli che vivono nell’Icam sono i primi ad esser presi e gli ultimi ad essere accompagnati dallo scuolabus. “Abbiamo chiesto e ottenuto massima collaborazione dal Comune e dal sindaco di Lauro – dice il sostituto commissario Felice Galeotalanza – Si tratta di una scelta fatta per garantire una forma di tutela e di privacy sul luogo di provenienza”. La giornata si divide tra le attività all’esterno per i bambini e quelle all’interno per le madri. Molte di loro lavorano nell’Istituto come cuoche, scopine o si occupano dell’orto. Poi ci sono i corsi di pasticceria e cucina, di decoupage, di cucito.
Sforzi che riescono solo in parte a smussare le discussioni tra madri, le piccole invidie e gelosie come in ogni comunità, le difficoltà ad affrontare una realtà che resta comunque pesante: quella di donne, alcune con condanne anche pesanti e per reati gravi, che hanno davanti a sé ancora anni di carcere. E vedono i loro figli crescere dietro quelle sbarre che il personale fa di tutto per far dimenticare, almeno ai più piccoli.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
La casa famiglia Ciao e la discrezionalità dei magistrati

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
La cosa più bella è il grande corridoio inondato dalla luce che entra dalle tre grandi finestre: i bambini giocano, corrono tra le gambe degli adulti e le loro voci rimbombano negli spazi vuoti. Benvenuti nella casa famiglia protetta dell’Associazione Ciao a Milano, una delle uniche due strutture in Italia previste dalla legge del 2011 in cui sono ospitate le madri detenute e i loro bambini. Attualmente ci sono 4 donne e 4 piccoli, divisi nei tre appartamenti a disposizione. Qui non ci sono sbarre alle finestre né personale della polizia penitenziaria, si possono tenere i cellulari e ognuno apre e chiude la porta quando vuole.
Andrea Tollis è il direttore. Ogni giorno ha a che fare con storie di emarginazione, con donne che hanno subito violenze e maltrattamenti, persone che non hanno nessuno che possa prendersi davvero cura di loro. “La tutela dei bambini e delle mamme sembra senza soluzione, perché è un argomento che suscita scandalo e vergogna e perché ha tante implicazioni tecnico-giuridiche che bisogna conoscere, a partire dal tema dell’esecuzione penale. Ma una soluzione c’è – rivendica spiegando il lavoro che dal 1995 viene fatto al Ciao - è mettere in atto misure concrete, capire quali progetti fare con le madri e soprattutto come proseguirli una volta finito il percorso ‘carcerario’. Serve dare una continuità ai progetti: non si tratta di spostare madre e figlio da un luogo all’altro e dargli un letto ma costruire un progetto intorno a loro, seguire la sua capacità genitoriale, mettere in campo progetti lavorativi, di formazione e di alfabetizzazione”.
Dalla casa famiglia le detenute possono anche uscire con i propri bambini. Due ore al giorno. Ci sono però delle regole: le forze di polizia possono entrare in ogni momento ed effettuare dei controlli, le donne ogni volta che escono ed entrano devono chiamare la polizia e dire che stanno uscendo o sono rientrare. Un altro piccolo passo in avanti rispetto agli Icam, un altro passaggio di quel percorso che, dice Tollis, si basa su un lavoro specifico: insistere sul “concetto di persona” e non dare a queste donne “l’etichetta di criminale o detenuto, capro espiatorio delle nostre coscienze”. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: la percentuale di recidiva tra chi esce dal carcere è del 68%, in coloro che godono delle misure alternative è del 16%. Ma è, purtroppo, un concetto che non passa nella nostra società.
E qualche responsabilità ce l’hanno anche i magistrati, se è vero che tutte le leggi negli ultimi 20 anni non sono riuscite a cambiare le statistiche e il numero di madri in carcere, finché non è arrivato il Covid, si è assestato sulle 50 all’anno. “C’è una dimensione che è ancora attuale ed evidente dal punto di vista del diritto – sottolinea Tollis - e cioè che la discrezionalità del magistrato a considerare misure cautelari di eccezionale rilevanza può porre un freno alla possibilità di una maggiore apertura sulle misure alternative. E’ un dato di fatto che per adesso la legge non è di per sé garanzia assoluta per evitare l’ingresso in carcere delle mamme e dei bambini”. Ed infatti fino ad oggi, conclude il direttore, non è accaduto: “perché come sappiamo le migliori intenzioni possono scontrarsi con la realtà”.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
La storia di Marina, il carcere era la vita di prima

Bambini dentro -
RIPRODUZIONE RISERVATA
Marina era una ladra. Ha fatto del male a tanti, portando via ricordi e pezzi di vita. Ha pagato. Marina ora è libera. E si è lasciata alle spalle il suo passato. La storia di Marina è l’esempio concreto di come i percorsi alternativi al carcere possano funzionare; di come i soldi stanziati dallo Stato e le energie spese da centinaia di persone che ogni giorno si dedicano ai detenuti non siano stati buttati.
Marina ha 4 figli, è stata arrestata nel 2011 e portata a San Vittore, da dove è poi stata trasferita all’Icam con il bimbo più piccolo. C’è rimasta un anno e mezzo e quando il bimbo ha compiuto tre anni si sono dovuti separare: lui in comunità, lei in carcere, a Bollate, poiché il regolamento attuativo della legge del 2011 non era ancora entrato in vigore. Ma nella sua testa era già scattato qualcosa e così, d’intesa con il magistrato e gli assistenti sociali, è iniziato un percorso che nel 2015 l’ha portata a riunirsi con il suo bambino, nella casa famiglia Ciao. Dove vive ancora con Antony, il più piccolo dei quattro.
“Prima che io entrassi in carcere la mia vita era in un campo, facevo la vita di un rom, andavo a fare i furti negli appartamenti, per noi era come un lavoro lì, pensavo fosse una cosa giusta” racconta guardandoti dritto negli occhi. Mentre era in carcere, il padre dei suoi figli ha avuto una storia con un’altra donna, che è rimasta incinta. E’ stata l’ultima goccia che ha spinto Marina a fare il salto.
“In tanti dicono che è pesante passare dal carcere. A me invece mi ha fatto crescere. Perché alla fine i reati che io commettevo facevano del male alle persone e quella non è vita, perché sono delle persone che soffrono. Ho capito che quando prendevo un oggetto io non conoscevo il valore che aveva per quella persona, non so cosa fosse, se era qualcosa di un caro che era morto o di una persona a cui tieni. Poi piano piano lo scopri e l’ho capito anche io quando mi hanno derubato. Ho capito che alla fine si fa solo del male alle persone”. Così questa ragazza ha scelto di non fare più quella vita, di ripudiare la sua cultura, “perché alla fine nella cultura rom sei obbligato ad andare a rubare perché è l’unico modo per vivere”
Marina queste scelte le ha pagate. I due figli più grandi hanno deciso di non seguirla e sono rimasti con il padre. La terza, una ragazza 13enne, vive in una comunità e il percorso per portarla con lei è appena iniziato ed è ancora lungo. Ma non ha alcuna intenzione di tornare indietro. E le sue parole sono pietre. “E’ tutta un’altra vita fare questa vita che ho scelto e non quell’altra. Il mio vero carcere era lì dove ero, non era il carcere quando ero dentro, io ero più libera in carcere che da mio marito, che sarebbe il padre dei miei figli. Io non conoscevo il mondo, ora sono libera di uscire, di fare quello che voglio, soprattutto ho imparato il mondo del lavoro, io lavoro. Tornare a casa e avere la soddisfazione che i soldi che io guadagno sono sudati ma non sono soldi facili”.
Non tutte le donne che passano per il carcere riescono a fare il percorso di Marina. “Purtroppo – racconta lei stessa - ci sono tante persone che quando vengono messe dentro dicono che vogliono cambiare vita però una volta che mettono fuori il piede non ce la fanno, anche tante mamme là dentro mi dicevano di volerlo fare ma hanno paura di farlo perché io sono una un po’ raro che ho fatto questa scelta. Penso che alla fine devi avere il coraggio di farlo”. Lei l’ha trovato, perché non è stata lasciata sola. “Io ho scelto questa strada giusta – ripete orgogliosa - e non ritorno più indietro”.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Magazine
Donne ultrà, in curva a tifare e sfatare il tabù
Le testimonianze di Stefania, juventina, Wanda laziale, Chiara e Anastacia romaniste, di una scrittrice e una giornalista, Marta Elena Casanova e Rosita Mercatante, che seguono l'universo femminile sugli spalti, il parere critico di Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, l'Associazione nazionale atlete, e quello vissuto di Beppe Franzo, storico ultrà della Juventus, il club che vanta il maggior numero di tifosi in Italia e autore a sua volta di testi sulla storia del tifo. Infine, la storia di Nadia Pizzuti, la prima donna a entrare (da cronista dell'ANSA) in uno stadio di calcio in Iran, a Teheran. Era il 22 novembre del 1997
La Corte Costituzionale si è pronunciata per due volte sul fine vita, ma in mancanza di una norma nazionale, le regioni vanno ognuna per conto proprio
Nel mito di Rocky, dove l'underdog è diventato campione
A Philadelphia tra gli eroi alla Balboa e la comunità italiana qui dalla fine del '700
Notizie ANSA Scegli l’informazione di ANSA.it
Abbonati per leggere senza limiti tutte le notizie di ANSA.it
Abbonati ora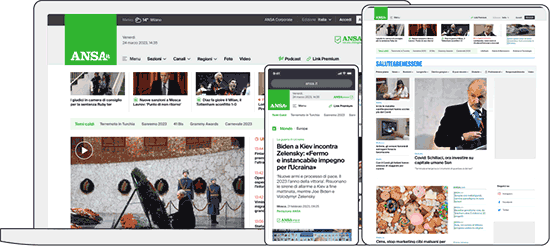
ANSA Corporate
Se è una notizia,
è un’ANSA.
Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.
Resta connesso
Ultima ora



